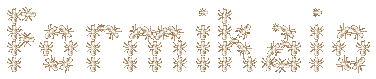Quando il nulla conquistò il regno dell’ovest il tempo sembrò decelerare, fino a fermarsi.
Tutto era cambiato a piccoli passi, impercettibili. L’odore della pioggia non era più lo stesso, le nuvole avevano un colore diverso. L’aria stessa era più rarefatta, più vuota, ma nessuno sembrava farci caso. Quella leggerezza, piuttosto, sembrava rendere tutti un poco più sani, se mi passate il termine. Era come assistere ad un aumento collettivo di grado nella scala cromatica delle emozioni. Col senno di poi chiunque avrebbe potuto smascherare l’impostura; una moltitudine spergiurò, anni dopo, di aver capito ogni cosa, e di non aver agito solo per timore. Eppure, in quella mansueta società di illusioni, tutti tacevano. Nel giorno fatidico erano in due al tavolino di un bar, davanti ai soliti caffè, poco distanti dal solito traffico; i caffè erano stati bevuti, poi gli aveva parlato per quasi venti minuti. Una storia di storie, di alieni, androidi, virus, replicanti, una storia di metafore, per cercare di raccontare il nulla che inonda e soggioga un’intera civiltà. Un crescendo tumultuoso di sensazioni, indizi e prove, ripercorrendo il proprio passato recente. E sentirsi cadere addosso, nel raccontare, la folle assurdità della propria teoria dell’invasione, del complotto globale. Un chiasmo, tra la vigilia dell’incertezza e l’incredulità sbigottita negli occhi dell’altro. Lo smarrimento, il senso profondo della sconfitta, un accenno di rancore; un rigo di lacrime su entrambe le guance. Poi il miracolo, lo sguardo di fronte che subitaneo si raccoglie, si acciglia, mormora, si apre, si spalanca, esplode. Rendersi conto che qualcosa è andato perso, che nessuno piange più nel regno dell’ovest, da chissà quanto tempo. Rendersi conto in un istante, piangendo, di avere tra le mani la chiave della rivoluzione che verrà. La chiave, un ponte di lacrime.